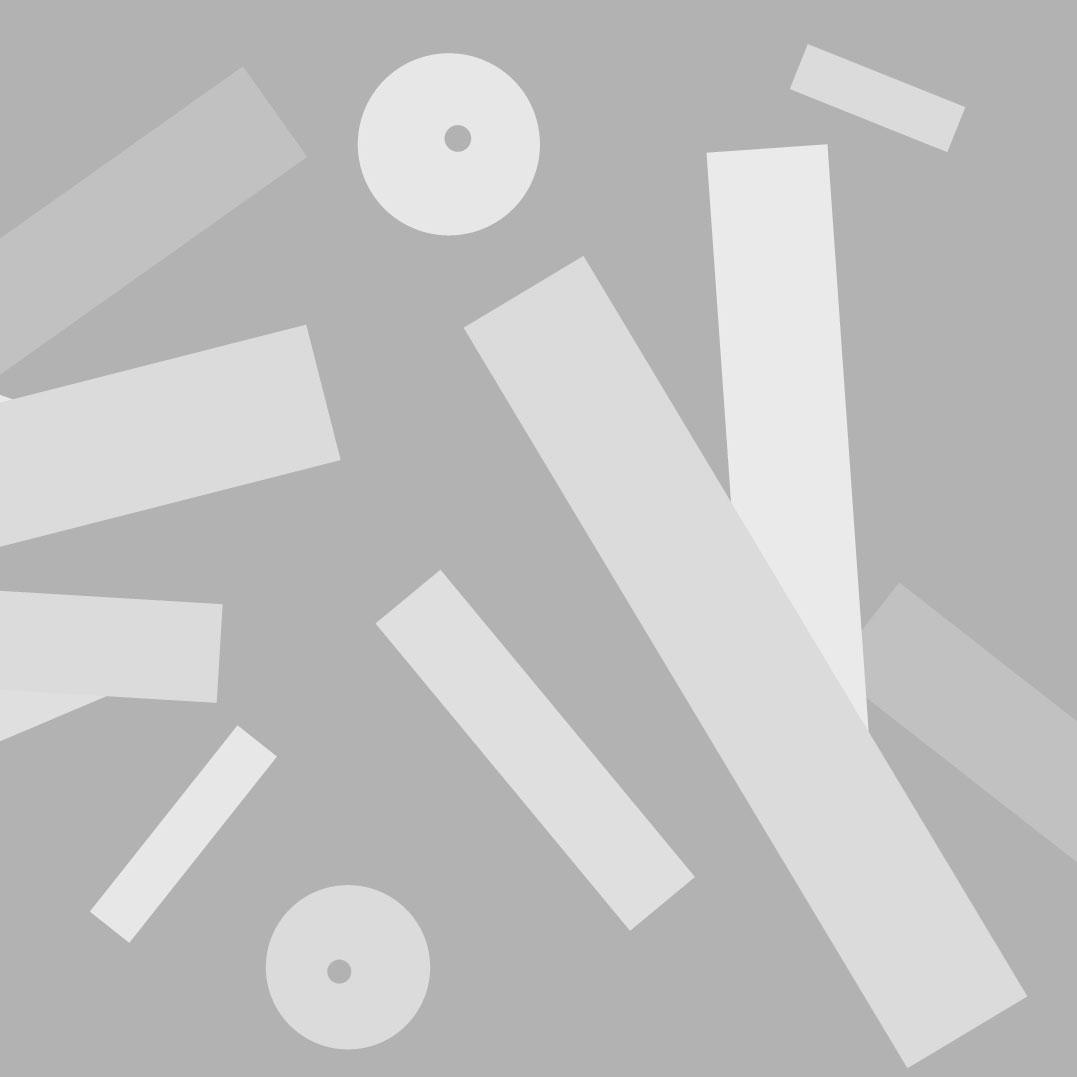Sala conferenze del Mart
L'ultima tempesta
Solo con la figlia (I. Pasco) su un'isola abitata da spiriti che con arti magiche ha messo al suo servizio, Prospero (J. Gielgud), spodestato duca di Milano, suscita una tempesta che fa naufragare i suoi nemici, ma con magnanimità rinuncia alla vendetta. P. Greenaway manipola a suo piacere La tempesta (1611-12) di Shakespeare che anche per lui è la grande tragedia rinascimentale delle illusioni perdute. Senza contare le interpolazioni sui 24 libri che raccolgono tutto lo scibile dell'epoca, nutrendo il potere magico di Prospero, il testo è ridotto a meno di un terzo. Tolto Gielgud che dà voce (quella di Gianni Musy in italiano) a tutti i personaggi, è un film senza attori recitanti, messo in scena come uno spettacolo allegorico di corte, proliferante in immagini e figure che, evocate dalle parole, si compongono, cambiano e si ricompongono. È un film meraviglioso anche nel senso di film sul meraviglioso, il più ricco e visualmente complesso di Greenaway che s'è servito della più sofisticata tecnologia giapponese per l'alta definizione elettronica. In un tripudio ridondante di arte rinascimentale che attraverso il barocco approda a un delirante rococò, ha fatto un'operazione di arte totale dove i mezzi tecnici della pellicola e del nastro elettronico assorbono musica, teatro, danza, pantomima, canto, disegno, scultura, pittura, grafica, animazione, collage, circo. Se non si accettano le regole del suo gioco (gusto per l'eccesso, dilatazione grottesca, dimensione metacinematografica, recitazione antinaturalistica, ecc.), il film si trasforma nella visita di un museo antico di cui s'è perso il catalogo.
(il Morandini)
Sono ventiquattro i libri che Prospero, personaggio de La tempesta di William Shakespeare, ha portato nell'isola dove è stato confinato. Essi raccolgono tutto il sapere umano e servono come metafora a Greenaway per costruire il suo film che invece di essere composto di inquadrature è, come suo solito, diviso in quadri. Il barocco e il grottesco qui raggiungono vertici che lasciano a volte imbarazzati. Estremizzando il suo metodo si passa da scene sott'acqua a strani balletti con minimi movimenti. La pittura a cui si è ispirato questa volta è quella di Tiziano Vecellio, quindi nudi a tutto spiano e non necessariamente ben modellati. Chi conosce il lavoro shakesperiano potrà apprezzare l'operazione. Gli altri probabilmente non sopporteranno il lungo monologo di John Gielgud. Splendide le musiche di Michael Nyman arricchite stavolta anche dalla partecipazione di ottime cantanti, prima tra tutte Ute Lemper.
(il Farinotti)
La critica
“Cartellone un film che inneggia al presidente della Biennale, il Portoghesi architetto, il concorso canta la gloria del cinema con la nuova opera dell'inglese impagabile Peter Greenaway: quel Prospero's books (in Italia si chiamerà L'ultima tempesta), in minima parte anticipato mesi fa da Cannes, che lascia, a dir poco, a bocca aperta. Venuto appunto dalla Tempesta di Shakespeare, il film suppone che sia il suo stesso protagonista a raccontare che cosa accadde, e accade tuttavia, nell'isola in cui è confinato il Duca di Milano spodestato dal fratello Antonio alleatosi col Re di Napoli. Fornito dal fedele servo Gonzalo di ventiquattro libri che coprono tutto lo scibile, Prospero si vale dei suoi poteri magici per inventare la memoria e simulare la realtà: per rievocare come arrivò in quella terra remota insieme alla figlia Miranda, vinse la strega Sicorace, soggiogò il mostro Calibano, liberò lo spirito Aríel, e per scatenare la tempesta che conduce nell'isola, naufraghi, Antonio e il Re di Napoli. Sventato il complotto messo su da Calibano, Prospero realizza il progetto di riavere il Ducato e di sposare Miranda al figlio del Re di Napoli. E quando ha ottenuto ciò che voleva, può rinunziare ai libri e alla magia e perdonare i nemici. A questo punto Prospero cessa di dare voce, lui solo, a tutti i personaggi. L'invenzione è finita, e l'ultimo libro distrutto sarà l'opera omnia di Shakespeare. Diremmo una bugia se affermassimo che la linea narrativa proposta da Greenaway è tutta facilmente afferrabile. Chi non ricorda bene il testo originale rischia di smarrirsi nella frondosa architettura del film, dominata dalla figura e dalla voce di John Gielgud e percorsa da infiniti echi figurativi, di referenze erudite e di prodigi d'illusionismo. La grande forza di Prospero's books è infatti nella stupefacente messinscena, che ripaga della sfocatezza del centro poetico. È nel modo con cui, valendosi della fotografia di Sacha Vierny, degli scenografi Ben van Os e Jan Roelfs, della musica sublime di Michael Nyman, ma anche della tecnologia elettronica giapponese, Greenaway fonde magia e cultura in una visionarietà zeppa di prospettive eccentriche. Col combinare l'antica ossessione dei numeri insieme alla disincantata passione del bibliofilo che sa come la conoscenza fornita dai libri procuri una finta realtà, Greenaway manipola il nostro patrimonio artistico quattro-cinquecentesco (Prospero ha il corno dogale, la Biblioteca Laurenziana riecheggia nelle sue stanze, la mitologia classica è riesumata in forme rinascimentali) toccando la vetta della sapienza registica. Balletto, spettacolo di corte, autoritratto di Greenaway per trasposti Shakespeare e Gielgud - il poderoso sir John in vista dei novanta - Prospero's books pecca se vogliamo per eccesso di ricchezza col suo sconcertante capogiro di costumi fastosi, di musiche, di corpi nudi, di nuvole di fuoco, di stregonerie che portate ai nostri giorni si esprimono nelle scene in cui dentro lo schermo c'è un secondo schermo. Ma raramente, forse mai, le magnifiche frodi del cinema ci hanno altrettanto aiutati a ricordare che non soltanto noi stessi ma proprio il cinema è della stoffa di cui sono fatti i sogni.”
Giovanni Grazzini (L’Indipendente, 7 settembre 1991)