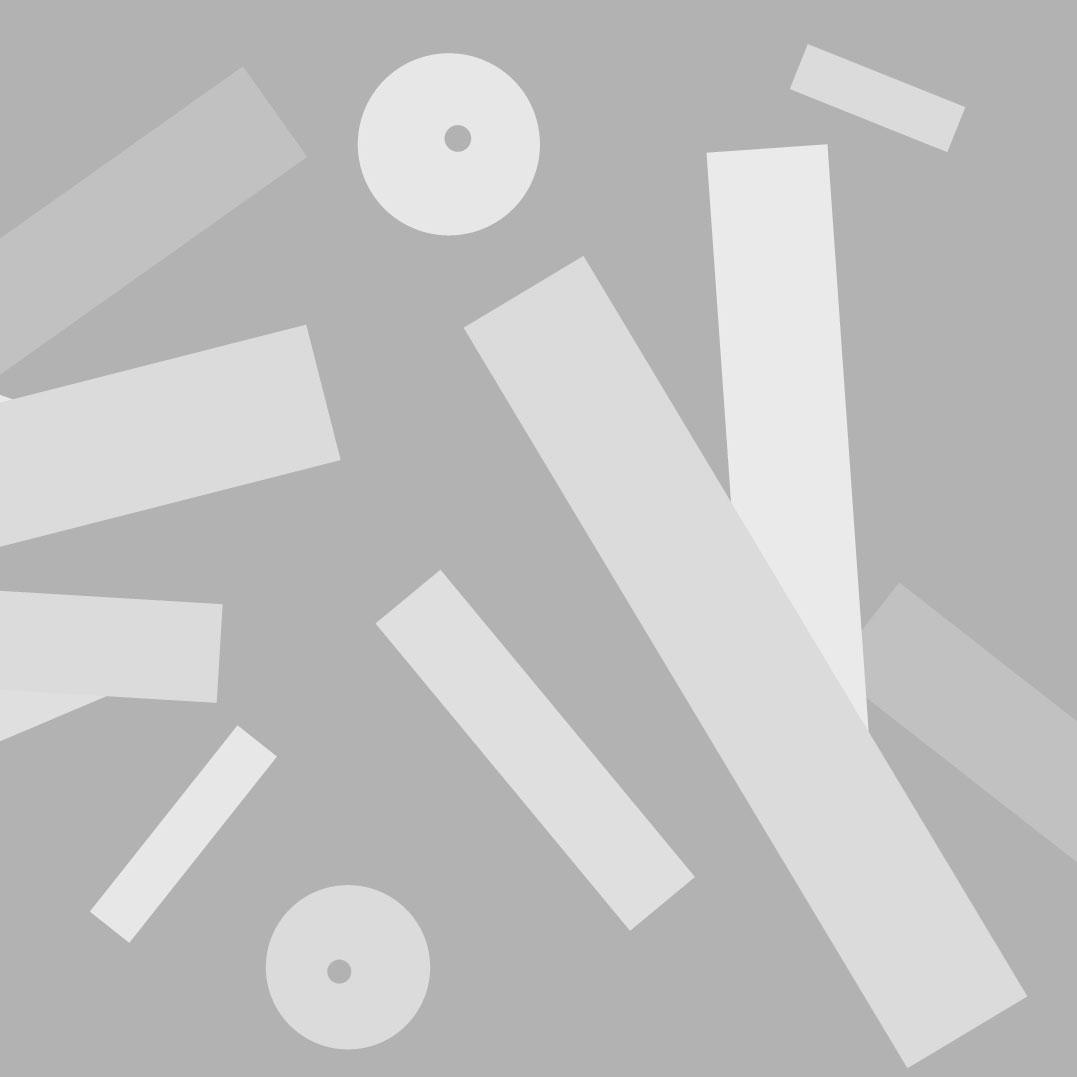Auditorium Melotti
Il tè nel deserto
Il tè nel deserto, seconda opera della trilogia dedicata a un mondo radicalmente estraneo al nostro, inizia in un modo dichiaratamente epico. I protagonisti si lasciano alle spalle la nave e il mare ma, diversamente da Odisseo, non pensano sempre al ritorno. La loro casa, che intravediamo durante i titoli di testa, è solo una grafica urbana in viraggio seppia; davanti al cielo e ai vasti orizzonti nordafricani New York assomiglia a una memoria, a un luogo morto. Nel film, tratto da un buon romanzo di Bowles, la matrice letteraria sostituisce quella pittorica o, meglio, la integra poiché il testo a cui la pellicola si riferisce è fortemente visivo. Il narratore, lo stesso Bowles nel ruolo sincretico del Fato e del Padre Tempo (quindi, per estensione, del cinema) ovvero di colui che tutto conosce in anticipo, si presenta come un vate composto e distaccato, omerico, lo specchio fedele di quell’eleganza rarefatta che caratterizza i protagonisti. Le parole e il volto del dandy Bowles corrispondono al dandysmo di Port e George mentre il vero eroe è la donna. La trasgressione iniziale di Port Moresby (John Malkovich), che si addentra nella notte africana appartandosi con la prostituta Mahrnia, bella «più della luna», rientra nel quadro della ricerca della madre, del viaggio psico-geografico compiuto da tutti i personaggi maschili di Bertolucci. Mahrnia, che assomiglia a una delle odalische dipinte da Ingres, accoglie l’americano sull’ampio seno: è l’Oriente esotico dei viaggiatori bianchi, una terra incognita e seducente seppure matrigna. Infatti la ragazza tenta di derubare il cliente che, recuperato il portafoglio, fugge da solo nell’oscurità, prefigurando la propria morte. La fitta rete delle citazioni - la trama che il regista tesse abitualmente intorno ai personaggi e al pubblico – dà il ritmo e conferisce spessore alla vicenda. Marito e moglie camminano insieme sotto il cielo che protegge: lui muore cercando invano l’altro se stesso delineato sulla superficie riflettente, lei – ben più vicina al segreto e al tesoro – si perde per riconoscersi infine nell’effigie dominante della madre-luna. Come si vede nel film c’è molto più di quello che sembra, non è una storia d’amore né una vacanza patinata per spettatori-turisti dello schermo esotico. Il set raffinato di Gianni Silvestri, i bei costumi di Acheson, le ventate fatali della colonna musicale firmata da Sakamoto incantano, certo, ma tale sipario estetizzante non nasconde bensì amplifica e illustra le vere intenzioni dell’autore, il progetto che Bertolucci non ha mai abbandonato, ovvero la ricerca di un mistero ricamato in cifra sulla tela delle vicende umane, perciò rintracciabile nel punto esatto in cui l’apparenza diventa essenza, nuda controparte della solitudine.