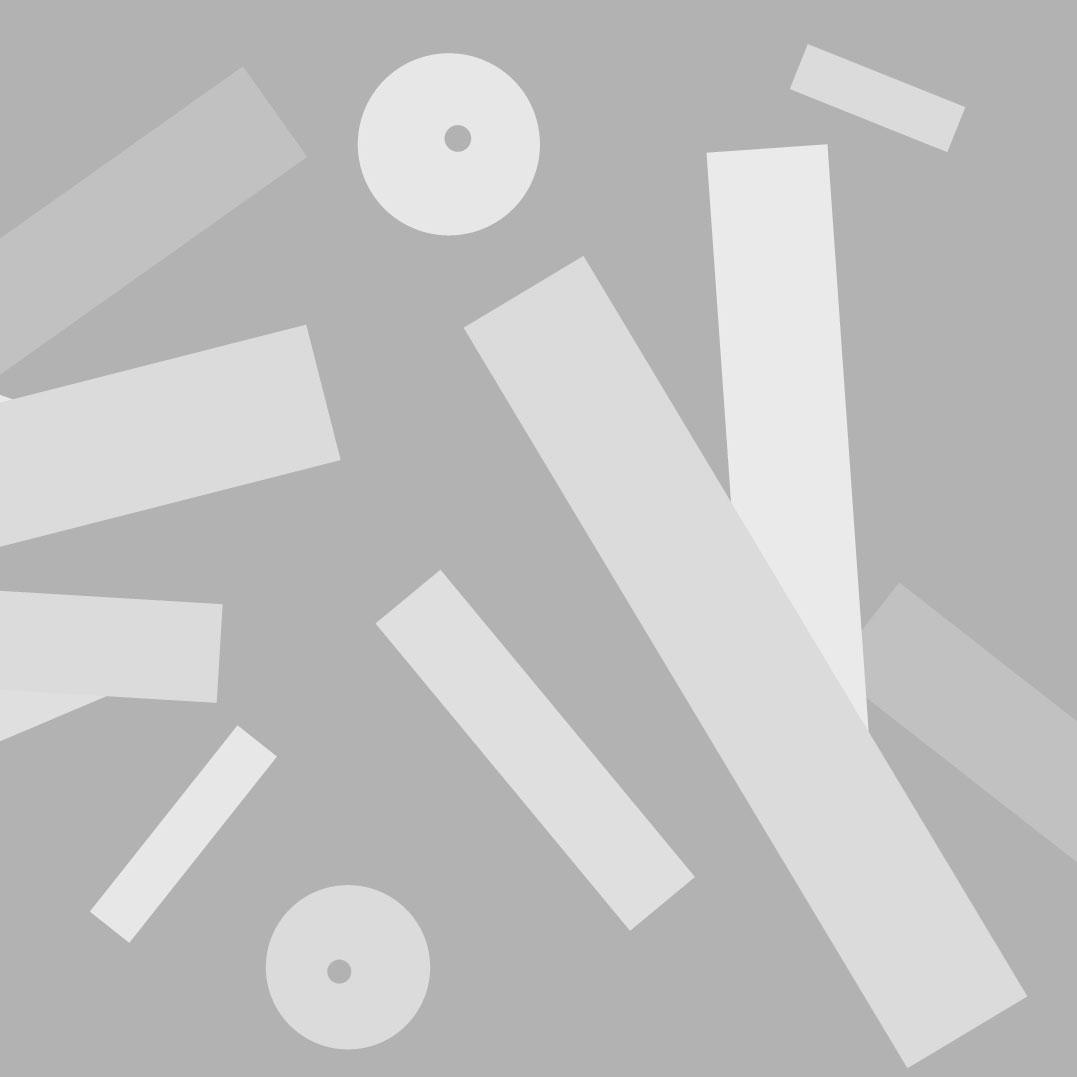Teatro Sociale
Sounddance
Ho allestito questa coreografia dopo nove settimane trascorse all’Opéra di Parigi. In quell’occasione avevo talmente sofferto che quando ho ripreso a lavorare con la mia Compagnia ho provato uno straordinario sollievo, come un’esplosione. Avevo voglia di creare una pièce vigorosa, rapida, complessa. Il titolo proviene dal Finnegans Wake di James Joyce: “all’inizio era la souddance (danza-suono o suono-danza).
Merce Cunningham
Nel 1973 il Festival d’Avignon e il Festival International de Paris commissionarono a Cunningham una nuova coreografia per ventisei danzatori del Balletto dell’Opéra di Parigi. La musica sarebbe stata creata da John Cage, le scene e i costumi da John Jaspers. Nacque Un jour ou deux (con una partitura musicale autonomamente intitolata Etcetera), la prima coreografia creata da Cunningham per una compagnia accademica: un balletto oggi considerato storico ma che allora costò ai suoi tre co-autori uno sforzo particolare poiché i ballerini non erano affatto abituati a danzare senza la musica o meglio con una musica disgiunta dai loro movimenti, né compresero come mai le scene e i costumi del balletto non avessero nulla a che fare con le altre componenti dello spettacolo. Per quanto traumatica, l’esperienza parigina ebbe conseguenze adrenaliniche su Cunningham: Sounddance - qui al suo debutto italiano - è una cattedrale di movimenti organizzati con tale fantasia e perfezione da lasciare ancora oggi stupefatto e incredulo lo spettatore. Soprattutto, viene percepita, a oltre trent’anni di distanza dal debutto, come un’esplosione di energia, tale e quale il coreografo la pensò e la volle all’inizio.
Forse questa identità tra le intenzioni dell’autore e la percezione del pubblico getta qualche ombra incredula sulla pratica aleatoria e casuale delle chance operations. In realtà, la stupefacente grandezza coreografica di Sounddance non fa che confermare ciò che resta spesso sottinteso nei procedimenti aleatori, nelle varie tecniche adottate per distanziare la soggettività dell’artista-creatore dalla sua opera: e cioè che la personalità, la cifra, il talento non ne vengono affatto depotenziati, anzi al contrario esaltati. Un coreografo qualsivoglia che crei un pezzo con pratiche aleatorie non assomiglierà per questo a Cunningham, così come nessun artista dell’immagine potrà pensare di somigliare a Jackson Pollock per il semplice fatto di gettare del colore sopra una tela. In altri termini le credenziali aleatorie di Sounddance sono indiscutibili: il pezzo nacque come work-in-progress all’interno di un event trasmesso dalla televisione, un cosiddetto Video Event e successivamente, nel 1975, debuttò a teatro, al Music Hall di Detroit. Ma da queste informazioni ricaviamo ben poco sul suo quid artistico. Preziose sono, comunque, le indicazioni dello stesso autore che puntualmente informa il suo biografo, David Vaughan, su come le condizioni di lavoro al parigino Palais Garnier si impressero nella sua mente, per esempio in termini di spazio.
La speciale compattezza di Sounddance e il tipo di energia, come compressa, che i dieci corpi in movimento debbono mantenere dall’inizio alla fine del pezzo nacquero dal ricordo del piccolo spazio di prova di Un jour ou deux. “Nonostante duri solo diciassette o diciotto minuti, la coreografia richiede molto impegno e sudore. Le entrate e le uscite avvengono attraverso una struttura in stoffa, installata a metà della scena. I danzatori vengono come spazzati via dentro un tunnel aerodinamico. Il movimento stesso si sviluppa dalla rigidità plastica della danza classica. In questo pezzo ho voluto molti movimenti e rotazioni del torso…Il punto di partenza della struttura è far entrare e uscire i dieci danzatori in modi diversi, gli uni appresso agli altri. Gli esercizi delle gambe e i movimenti del torso sono complessi. L’insieme dà l’impressione di uno spazio osservato al microscopio”. Il coreografo aggiunge altre annotazioni sulla musica di David Tudor che ha qualcosa di fascinosamente futurista: il suo primo titolo fu Toneburst poi mutato dallo stesso Tudor in Untitled 1975/1994 in occasione di una nuova versione della coreografia, rimontata da Chris Komar e Meg Harper, cui si deve l’ultima odierna ripresa. “E’ una musica elettronica sostenuta e pulsante, che crea un ambiente sonoro molto denso”. A questa densità il décor di Mark Lancaster aggiunge un turgore barocco, dalle tonalità della sabbia, qualcosa di antico, nobile e gioioso: come i costumi dai top ancora color del sole.