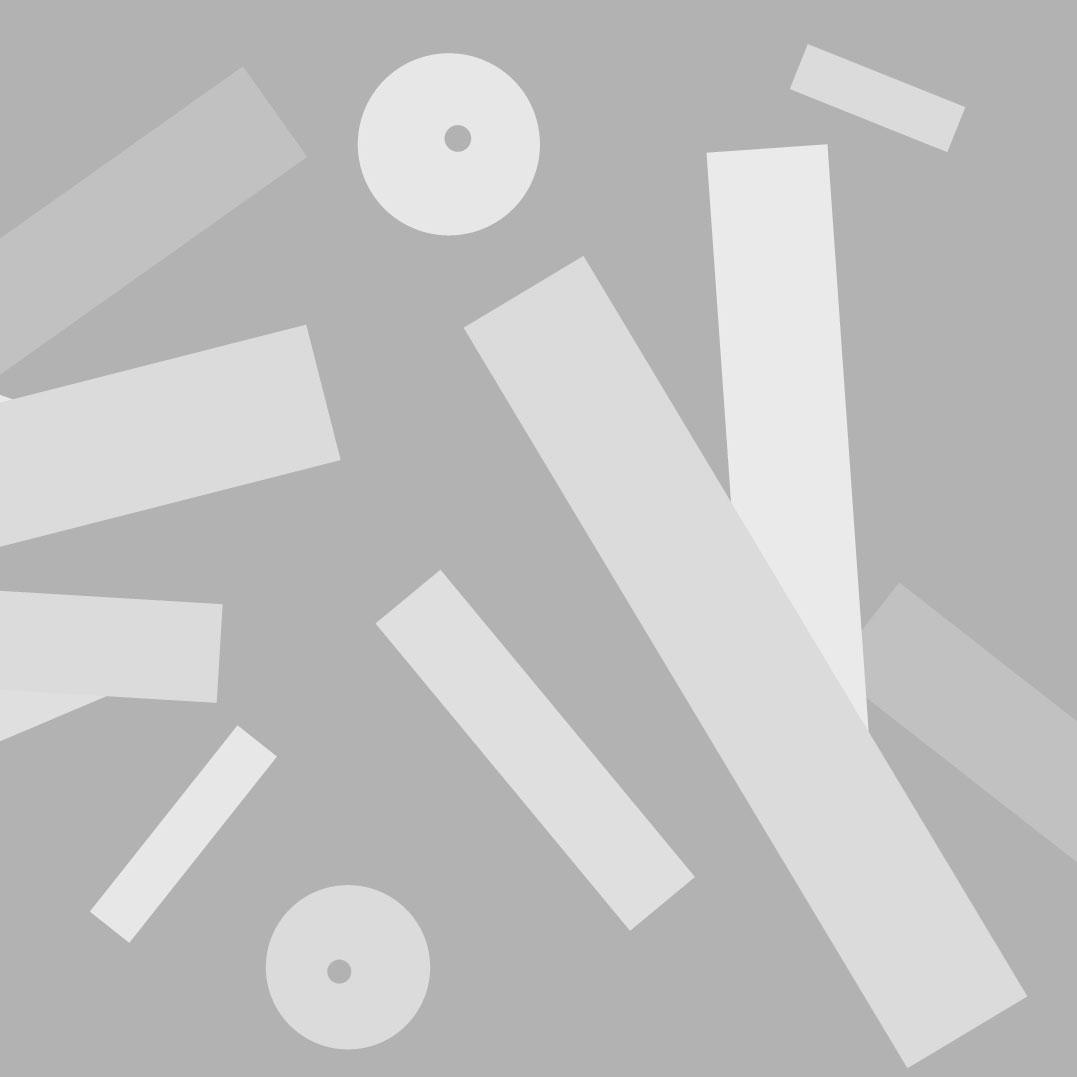Sala conferenza del Mart
I misteri del giardino di Campton House
Inghilterra della Restaurazione, 1694: signora chiede a pittore di eseguire dodici disegni della sua residenza da donare al marito che l'ha sposata per interesse, purché ogni giorno, finito il lavoro, si sollazzi con lei a letto. Ma il marito viene trovato annegato in un fosso. All'insegna di una sofisticata e secca stilizzazione, racconto di figure in un paesaggio, commedia grottesca dell'assurdo, è un film sull'arte e sul sesso, rappresentati entrambi come lavoro e subordinati agli interessi economici. È anche un saggio critico sul diritto di proprietà come motore della vita sociale. A modo suo, è un film perfetto per la precisa e calcolata congruenza delle parti con il tutto. Bella colonna musicale di Michael Nyman. Premiato alla Mostra di Venezia, diede a P. Greenaway rinomanza internazionale.
(il Morandini)
In una villa della campagna inglese, alla metà del Seicento, un pittore riceve l'incarico dalla proprietaria, Lady Herbert, di eseguire dodici disegni della sontuosa dimora. Per convincere il riluttante pittore inserisce nel contratto la clausola per cui lei gli si concederà alla fine di ogni disegno. Il pittore si mette all'opera, ma nel paesaggio compaiono inquietanti oggetti: farsetti bagnati di sangue, camicie strappate, indizi di un delitto: quello del castellano, che sarà trovato ucciso in giardino. I suoi disegni sono diventati documenti dell'intrigo mortale, e il pittore, che nel frattempo ha ottenuto anche i favori della figlia degli Herbert, sarà a sua volta ucciso.
(il Farinotti)
La critica
“Da dove avrà ricavato l'ottimo esordiente Greenaway il soggetto dei suoi «misteri»? Da un manoscritto rinvenuto alla fine dell'Ottocento in un maniero inglese? Dal taccuino vendicativo di un suo antenato cattolico? No, l'ha preso nella sua testa, forse giocando a fare l'inglese come se fosse un letterato europeo un poco manierista. Si capisce che il tema (l'ambiguità del reale e la sudditanza dell'artista) è molto moderno, nasce in un'immaginazione che ha già conosciuto Losey, Kubrick e Antonioni, oltre ad aver frequentato la grande pittura di Inghilterra e del continente. Da una parte c'è la scena, la villa e i giardini, dall'altra c'è il testimone, il pittore Neville, in mezzo c'è lo strumento della mediazione, la pittura, l'inquadratura, l'illusione di scomporre la realtà in un reticolo esatto e incontestabile. La nobile padrona di casa, per fare un regalo al marito che è partito per un viaggio, chiede al pittore di dipingere la villa e i giardini, aggiungendo la condizione libertina che egli, per guadagnare del tutto il compenso, ogni sera fornisca una prestazione galante. Tutto questo non è molto inglese? Ma col passare delle pennellate e dei convegni con la dominatrice signora, si annunciano ostacoli inquietanti; non solo la figlia della nobildonna, infelicemente maritata, pretende le stesse prestazioni concesse alla madre (fa parte degli equilibri di famiglia), ma i giardini svelano nel quadro un mistero, il sospetto che il marito non sia affatto partito, ma che sia stato ucciso e che il suo cadavere giaccia nascosto in qualche parte. È vero, il delitto c'è stato, l'arte sembra avere conquistato una splendente vittoria sulla corruzione dei potenti di tre secoli fa, però vedrete che è per poco, l'ultima parola spetta sempre al committente, l'arte anche quando scopre la verità non cessa di essere ancella. Curatissimo nelle scansioni visive, pungente nei personaggi di contorno, compreso un simbolico convitato di pietra, il film di Greenaway (intitolato semplicemente nell'originale Il contratto del disegnatore) è una bella prova di intelligenza unita a una naturale scaltrezza)”
Stefano Reggiani (La Stampa, 27 novembre 1983)
“Nella baraonda di Venezia c'è sempre qualche film che viene preso sottogamba dalla critica sfiancata. Alla Mostra del 1982 una delle vittime fu The Draughtsman's contract (Il contratto del disegnatore) , il quale vinse uno dei premi AGIS-BNL ma fu liquidata da molti cronisti, anche da noi, con una certa insofferenza, alla quale probabilmente non erano estranei i sottotitoli italiani, insufficienti a esprimere le sfumature di un parlato molto denso e letterario. A mente riposata, e grazie anche agli eccellenti dialoghi di Masolino d'Amico, il film che ora si intitola I misteri del giardino di Compton House ottiene l'attenzione meritata da un'opera molto originale, di grande eleganza intellettuale. Né facile a interpretarsi né da tutti godibile, ma curiosamente percorsa di segni occulti, di giochi di parole e di ambigue simmetrie, tutti elementi di una struttura espressiva che replica l'equivoco della realtà, col suo enigmatico rapporto fra ciò che l'occhio vede e la mente capisce (siamo nei paraggi di Blow-up).
Scritto e diretto dall'inglese Peter Greenaway, un pittore-cineasta di 41 anni che viene dall'avanguardia, il film è in sostanza un thriller. Nell'Inghilterra di fine Seicento la ricca famiglia Herbert abita una sontuosa villa di campagna. Poiché fra i coniugi sono nati dissapori - sembra che Mr. Herbert simpatizzi un po' troppo col giardiniere - per riportare la pace la padrona di casa vuole commissionare al pittore Neville una serie di disegni della villa e del giardino, da regalare al marito quando tornerà da un breve viaggio. Almeno così dice. Neville accetta soltanto a condizione che Mrs. Herbert, dopo ogni disegno, gli conceda le sue grazie. Firmato il contratto, la signora lo rispetta, ma il pittore non ottiene che nelle ore stabilite il giardino sia perfettamente in ordine, sgombro di persone e di cose. Qualcuno lo dissemina di oggetti che potrebbero essere gli indizi di un raggiro nel quale siano coinvolti gli Herbert, e i loro ospiti. Neville cerca di rappresentare il vero interrogandosi sulle sue apparenze, ma a sua volta entra involontariamente nel gioco quando, rovesciandosi i termini del contratto, è la figlia di Herbert, moglie senza prole di un tedesco impotente, a offrirsi al pittore col pretesto di indurlo così a non rivelare i suoi sospetti. Neville acconsente di buon grado, ed è la sua fine. Scoperto il cadavere di Mr. Herbert (non sapremo chi l'ha ucciso: forse l'amministratore, amante della moglie, forse un servo burlone), ottenuto che il pittore rendesse fertile la giovane donna e il patrimonio restasse in famiglia, Neville è un testimone da eliminare. Dopo averlo accecato lo uccidono e ne bruciano i disegni.
Il maggiore motivo d'interesse offerto dal film, prodotto dal British Film Institute e dal quarto canale della Tv inglese, non risiede nella sua trama (i più aggiornati direbbero nel plot), ma nei modi in cui si sviluppa: nel rapporto fra il tessuto narrativo, con la sua critica ai costumi d'una nobiltà cinica e viziosa, e il processo formale simbolizzato dal ricorso a quella sorta di pantografo di cui il pittore protagonista si serve per incorniciare l'oggetto del disegno, a simiglianza della macchina da presa che inquadra la scena. Nella dialettica fra la pretesa di Neville, il quale dispone di uno strumento che vorrebbe artificiosamente costringere il flusso della realtà in dimensioni geometriche, e l'ironia di Greenaway che ci ricorda quale uso facciano dell'artista i potenti e come un fossato divida il fenomeno dal noumeno, sta la molla del film. Lo spettatore bene educato saprà dunque coglierne l'interna dinamica: l'universo congetturale in cui ridicolmente si iscrivono le rigide norme del contratto e i cerimoniosi comportamenti dei personaggi caratterizzati da enormi parrucche, le “scene di conversazione” distese in forbiti e spesso capziosi dialoghi, la recitazione fredda degli attori (non a torto sono stati fatti i nomi di Rossellini e di Straub) in quel paesaggio pettinato che ricorda Poussin e Lorrain, una fotografia memore delle luci caravaggesche, una musica modellata su Purcell, e il controcanto irrazionale e derisorio affidato al servo nudo che di notte si finge una statua e sconvolge l'armonia del giardino.
Pregiudizialmente ostile al cinema realista, erede d'uno sperimentalismo sofisticato ma acuto, Peter Greenaway si rivela un autore di tutto rispetto, che conferma la fertilità del vivaio britannico. Benché il pubblico italiano possa trovarlo aulico e verboso, il suo film è stilizzato con una coerenza compositiva che chiede di essere apprezzata. Come conviene a un “giallo” molto dotto, dove l'intrigo è una metafora delle simulazioni della Storia, e chi le decifra, dopo essersele godute, ci rimette la pelle”.
Giovanni Grazzini (Il Corriere della Sera, 5 novembre 1983)