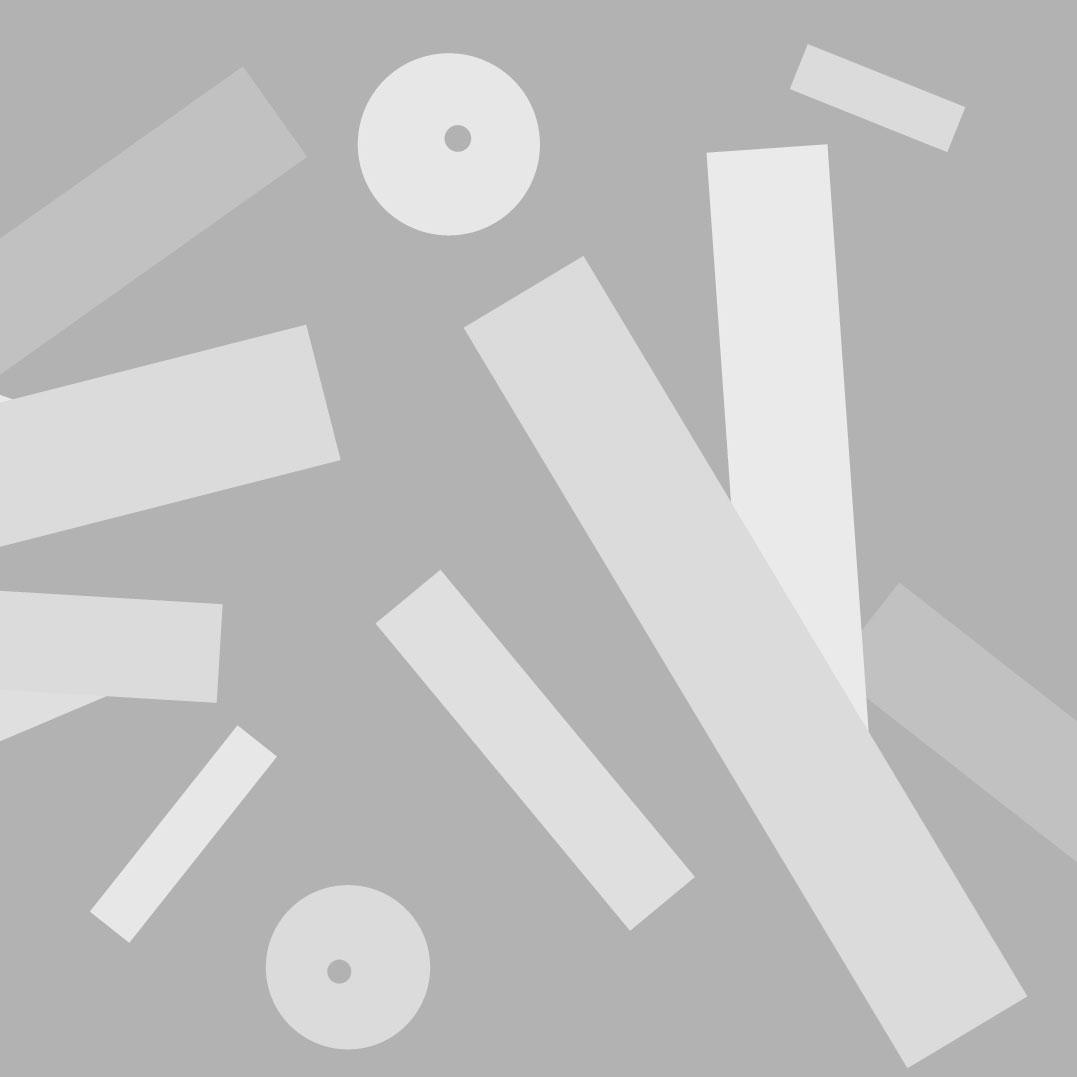Auditorium Santa Chiara
Cantico
Nel 1975 Guido Ceronetti pubblicava con Adelphi la sua vibrante traduzione italiana de “Il Cantico dei Cantici”, seguita da uno straordinario saggio sull’argomento. All’illuminante lettura di Ceronetti fa riferimento Virgilio Sieni, autore per Oriente Occidente e per il Centro di Santa Chiara di Trento di una creazione ispirata al testo di Salomone. Già ospite a Rovereto nell’89 con “Studi su Nijinsky”, Sieni, che è senza dubbio uno dei più intelligenti coreografi italiani contemporanei, è autore di una ricerca sul gesto sviluppatasi attraverso un percorso nel tempo fedele a se stesso. La sua è una danza astratta, metaforica, in cui il movimento è fortemente calato nel “rito”, perché – come il medesimo autore scriveva nell’88 – “ha lo stesso scopo di rammentarci l’archetipo”. In Sieni il gesto non ha bisogno di supporti narrativi, perché già “contiene in sé l’energia narrativa” (Atti del Convegno di Modena “Le Forze inn Campo”, 1986). Il suo segno, contrario all’autobiografismo, tende ad una astrazione simbolica, iscrivendo nello spazio forme che trascendono il quotidiano. Formatosi tra Firenze, Amsterdam, Tokyo e New York, ha lavorato dal ’78 all’83 nella compagnia Group/O di Katie Duck, per poi collaborare, una volta rientrato a Firenze, con il gruppo teatrale I Magazzini di Federico Tiezzi. Con Parco Butterfly, la compagnia da lui fondata nell’83, ha creato inizialmente brani di stampo teatrale come “Momenti d’ozio” o “Shangai Neri”, per poi spingersi sempre più verso opere dal registro coreografico. In questi dieci anni ha firmato moltissime creazioni: tra esse citiamo almeno “Fratello Maggiore” (’87), “Duetto” (’89 – in collaborazione con Alessandro Certini), le frequenti improvvisazioni su musica dal vivo (partners compositori come Steve Lacy ed Evan Parker), “Apollon Musagète” (’89), “Pulcinella” e “Trait d’union” (’90) e “Chi vuol esser lieto sia” (’92) per il Balletto di Toscana. Ultimamente ha lavorato, sotto la nuova sigla Compagnia Virgilio Sieni Danza, ad un progetto triennale sulla figura di Ulisse, inteso come personaggio contemporaneo, di cui “L’Eclisse”, dedicata a Michelangelo Antonioni, è una delle tappe più significative. Profondamente suggestive infine le sue letture coreografiche ispirate a Re Lear e il recente Amleto/Ofelia. Dalla sua introduzione alla creazione che debutterà a Trento, merita citare almeno qualche stralcio tra i più significativi: Penso alla danza come alla poesia, dove ogni parola e suono, ogni intervallo e pausa, la partitura e la metrica, acquistano un valore “altro”, tessono nell’immediato un filo diretto, carico d’energia vitale, con il mondo dell’immaginazione. Immaginare diviene quell’atto dove disciplina e sacralità si incontrano. La parola non può descrivere la danza; il linguaggio della danza, nella scientificità e metafisicità del corpo, nella complessità e limpidezza del movimento che nasce, non può confrontarsi con la parola se non come elemento “ritmico/aritmico”, come materia di un risuonare interiore. Il pensiero e la danza, la parola e il movimento, ciò che la parola significa e il movimento perpetua, ciò che il movimento significa e la parola non eguaglia. Il giardino di Querelle nel film di Fassbinder è forse quell’orto pieno di odori e colori narrato nel “Cantico dei Cantici”. Ci si chiede se ogni frammento di vita, che precede la scrittura, comprenda quel giardino erotico e sensuale, quell’odore che emana da tutto il “Cantico”, “superando ogni profumo”. “Mi abbeveri di baci la tua bocca”: una coppia di giovani nomadi d’oriente nella loro tenda blu, ragazzi catalani sotto un cielo stellato; ma anche ragazzi di periferia. Due danzatori che nello spazio vuoto passano e si fermano. Un’azione che nasce lì, che da lì, in continua evoluzione, nell’irripetibilità del momento, inebria di movimento ogni particella. La lettura/suono del “Cantico” avvicina alle sottili correnti che passano quando un movimento si compie per la prima volta, a quel silenzio che comprende sia il caos che l’ordine, il disarmonico e l’armonico, l’odio e l’amore. “…il vuoto del Cantico è per confermarne la sacralità. Tutto quel che è vuoto, il “vacuum” lucreziano, un deserto, una fossa, una stanza, una carcassa, uno scatolino, è una parte del Grande Mistero, significa attesa di Qualcuno o Presenza occulta… IL CANTO È VUOTO / IL CANTO È MUTO / LA NOCHE OSCURA”.