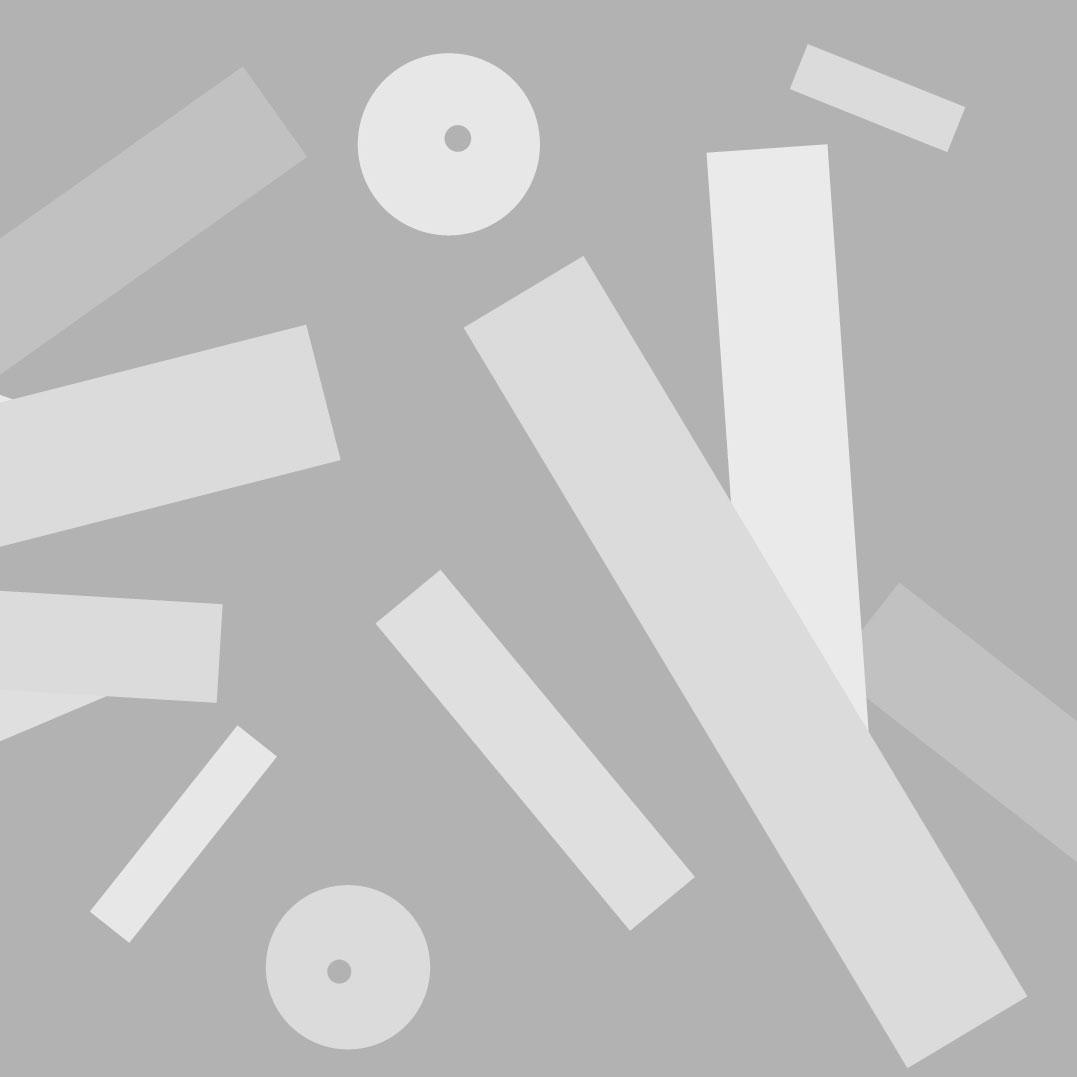Teatro Zandonai
Accumulation plus Talking with Watermotor
Dalla danza post-modern degli anni ’60, fondata a partire da un ripensamento sull’arte del movimento i cui presupposti rimettevano in discussione lo stesso concetto di tecnica, alla creazione negli anni ’80 di opere per gruppo nutrite di un rigoroso metodo matematico di composizione, fino alla riflessione degli anni ’90 dedicata al confronto della danza con opere esemplari della tradizione musicale occidentale, Trisha Brown ha dato al suo lavoro il respiro di una ricerca in sviluppo costante, articolata in corposi cicli di sperimentazione. Merita ritracciarne le linee. Le origini della post-modern dance americana, risalenti all’inizio degli anni ‘60 fanno capo alle classi di composizione tenute nello studio newyorchese di Merce Cunningham da Robert Dunn. Lì si posero le premesse per lo sviluppo della generazione di artisti capitanata da Yvonne Rainer, Steve Paxton, Trisha Brown, Simone Forti, Lucinda Childs, Laura Dean, Deborah Hay, David Gordon. In opposizione al virtuosismo segnico e ai codici di movimento sia della modern dance (si pensi alla tecnica Graham) sia del balletto classico-accademico, Brown e compagni affrontarono il problema di ridefinire il mezzo danza, rompendo con il passato per cosiderare secondo nuovi presupposti il rapporto tra corpo, spazio, tempo, luogo di rappresentazione, pubblico e qualità della performance. Molti dei danzatori che frequentavano le classi di composizione di Dunn, influenzate dalla ricerca di John Cage, diedero il via alle loro sperimentazioni collettive alla Judson Church di New York, spazio frequentato, oltre che da giovani interessati alla coreografia, da pittori, scultori musicisti e scrittori d’avanguardia (bastino i nomi di Robert Rauschenberg e Robert Morris), e che contribuì a far si che la danza fosse analizzata anche in relazione alle altre arti. Rispetto al movimento, azioni ordinarie come la corsa e il camminare divennero materiale del vocabolario di danza così come oggetti presi dalla vita quotidiana entrarono a far parte delle composizioni. Costumi, luci e scene venivano scelti in base non alla loro spettacolarità, ma alla loro funzionalità in rapporto al mutamento dei luoghi della rappresentazione, non più teatri tradizionali, ma chiese, piazze, strade, gallerie d’arte. Nel 1970 nacque il collettivo di improvvisazione The Grand Union, nel quale accanto a Steve Paxton, Yvonne Rainer, Barbara Dilley, Douglas Dunn, Nancy Green, David Gordon, lavorò anche Trisha Brown. Nei pezzi della Grand Union il mezzo danza venne ridefinito alla luce delle sperimentazioni sul corpo portate avanti dai singoli artisti del collettivo (si pensi agli studi sul movimento di coppia e di gruppo della contact-improvisation messi a punto in quegli anni da Steve Paxton), ma anche in rapporto ai possibili risvolti psicologici e sociali del gesto. Si apriva così la via al recupero di quell’aspetto narrativo della rappresentazione estraneo alla cosiddetta fase analitica del primo post-modern. Conclusa la fase di rottura con la modern dance, il balletto classico e il momento di sperimentazione al di fuori dei circuiti tradizionali di rappresentazione, artisti come Lucinda Childs (legata agli inizi della sua carriera al Judson Dance Theatre) e Trisha Brown, forti della ricerca condotta sui principi del movimento e sulle regioni del corpo, ricucirono lo strappo iniziale con il passato, riappropriandosi dei codici e delle tecniche, dei mezzi teatrali, del rapporto tra musica e movimento. Dei lavori in programma a Rovereto – esemplificativi delle varie fasi di ricerca affrontate dalla Brown – Accumulation plus Talking with Watermotor, danzato dalla stessa autrice, ripropone lo stile delle famose accumulations degli anni ’70, pezzi costruiti a partire da un semplice movimento del corpo, al quale ne venivano aggiunti via via degli altri fino alla costruzione di una sequenza completa, riproposta ogni volta dall’inizio. Tra la fine degli anni ’70 e la fine del decennio successivo, la Brown firmò in collaborazione con Robert Rauschenberg capolavori quali Glacial Decoy (’79), Set and Reset (’83), Astral Convertible (’89): in quest’ultimo l’artista lavorò sull’idea della prospettiva, creando una danza orizzontale, sul pavimento, per il pubblico che vedeva lo spettacolo dall’alto, ed una danza verticale per gli spettatori della platea, interessandosi tra l’altro al confine tra movimento con significato e movimento senza significato. In Set and Reset, secondo titolo della Brown in programma al Festival, l’artista celebra la poetica dello slancio ininterrotto al limite della stabilità, principio base di una coreografia fluida, quanto strutturata, arricchita dal confronto con la “presentazione Visuale” firmata da Rauschenber, di cui elemento chiave solo le proiezioni diafane e trasparenti che appaiono sopra i danzatori. Con If you couldn’t see me, del ’94, la Brown è tornata a coreografare, a distanza di quindici dal suo ultimo assolo, una creazione per sé. Si tratta di un pezzo di circa otto minuti, danzato, su suggerimento di Robert Rauschenberg, autore di musica e costume, di schiena dall’inizio alla fine. Per questo brano l’artista ha lavorato su due concetti chiave: la reificazione del corpo (“mettere in scena il corpo come se si trattasse di un oggetto”) e il narcisismo. Una tematica quest’ultima affrontata dalla Brown fin dai tempi del post-modern quando era considerato “politicamente non corretto” fare esibizione narcisistica del proprio talento. Là la soluzione era riportare la danza alla semplicità del movimento pedestre, qui è cercare una comunicazione con il pubblico tramite una danza di schiena privata del rapporto frontale con gli altri. If you couldn’t see me si sviluppa a partire da un’energia circolare, messa in moto da impulsi, slanci, oscillazioni. Una gamba allungata verso l’esterno in una sequenza morbida dà un impulso al corpo che si sposta a sua volta come un’onda nella direzione indicata dal movimento periferico dell’arto inferiore. Il fianco slitta su un immaginario piano orizzontale, dando un imput alle braccia che risalgono parallele veso l’alto in un moto rotatorio foriero di altre escursioni nello spazio. Finchè il movimento torna alla quiete con un gesto quadrato, in equilibrio con l’asse verticale del corpo. M.O. e Twelve Ton Rose costituiscono infine le due prime tappe della trilogia dedicata negli anni ’90 al confronto con la tradizione musicale occidentale che si chiuderà nel ’98 con l’Orfeo di Claudio Monteverdi. Per M.O. ispirato all’Offerta Musicale di Bach, la Brown ha studiato per un anno la polifonia barocca e la letteratura bachiana, insegnando alla sua Compagnia a leggere la partitura e a comprenderne regole e forme. Per confrontarvi poi la sua personale polifonia coreografica, sorta di “forma nella forma” che non illustra in modo didascalico le tredici sezioni della musica bachiana (due fughe, dieci canoni e una sonata a trio in quattro movimenti), ma non ne è nemmeno indipendente. Il risultato è una danza che si colora nel finale di una curiosa ambiguità emotiva data dal mutamento dello sguardo della danzatrice principale, uno sguardo che smette ad un tratto di proiettarsi attraverso lo spazio per “guardare” lo spazio: differenza che invita a leggere la duplice polifonia coreografica e musicale in una prospettiva nuova.